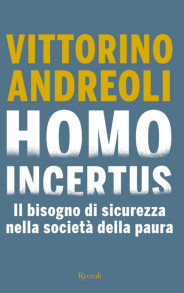Il bisogno di sicurezza è insito nell’essere umano, ne determina in modo incontrovertibile la stessa sopravvivenza, pur essendo realmente impossibile da soddisfare; Maslow la pone persino alla base della sua piramide dei bisogni primari dell’uomo.
In principio ci fu Charles Darwin. Fu lui a delineare per la prima volta, nella metà dell’Ottocento, con l’emblematico L’origine delle specie, i tre imperativi necessari affinché un singolo uomo e la specie umana sopravvivano nell’ambiente. Il primo fa riferimento al reperimento del cibo; il secondo alla procreazione; il terzo alla necessità di rendere sicuro il territorio in cui si vive. A centosessant’anni di distanza, possiamo affermare che gli imperativi darwiniani sono da ritenersi ancora validi, benché considerevolmente ridimensionati nella loro importanza. Se l’attenzione verso i primi due imperativi è andata scemando nel corso tempo − complici una disponibilità di materie prime alimentari pressoché illimitata e una natalità costantemente monitorata − l’ultimo ha acquisito una pluralità di significati che non aveva fino al secolo scorso: non si parla più solo di difesa del territorio assicurata dalle forze dell’ordine e dall’esercito; occorre accettare il fatto che il principio di difesa territoriale proposto da Darwin si sia progressivamente frammentato, acquisendo una dimensione individuale per cui ogni individuo è nemico per l’altro. Il territorio da difendere non è più la proprietà comune ma quella personale.
Di ciò si parla ampiamente nel nuovo libro di Vittorino Andreoli, Homo Incertus: Il Bisogno di Sicurezza nella Società della Paura, edito da Rizzoli.
Nella sua accurata analisi della società contemporanea, dei suoi bisogni e delle sue infinite contraddizioni, Andreoli attua anche un breve excursus sui bisogni indotti; non necessari, dunque, alla sopravvivenza della specie ma all’arricchimento di un’elite: «A sessantacinque anni di distanza [dall’ideazione della piramide di Maslow], la società è notevolmente cambiata», scrive l’Autore.
A tali bisogni “fluttuanti” si sono aggiunti bisogni che trascendono quelli corporei e che si riferiscono ai sentimenti, ambito della psicologia. Internet si è reso poi artefice della creazione di un mondo nuovo, parallelo a quello reale, predisponendo la nascita di nuovi desideri che si collocano nel virtuale.
Ecco dunque che i bisogni diventano illimitati e imprevedibili e producono un vero e proprio sconvolgimento delle economie, poiché è impossibile trovare le risorse per soddisfarli pienamente.
«In questi anni stiamo assistendo alla perdita da parte dell’uomo del suo compito a livello occupazionale, la contrazione di posti di lavoro che superficialmente viene riferita a un crollo dell’economia e che deriva invece da un mutamento nella produzione che prevede sistemi a costo inferiore rispetto all’attività umana», afferma Andreoli, «è chiaro che, se l’industria produrrà senza l’uomo, i profitti finiranno nelle mani di pochi, mentre attorno dominerà la povertà. La massa povera non potrà acquistare i prodotti industriali; per contro, i robot −i nuovi lavoratori − non saranno affatto interessati ad acquistare un’automobile o uno smart phone. La povertà, poi, riporterà ai bisogni primari e non avrà motivazioni per aspirare a quelli dell’inutile». Pare, dunque, che seguendo la logica del profitto si sia perso il significato stesso dell’esistenza umana.
A tale allarmante condizione sociale Andreoli contrappone l’esempio virtuoso del nascente minimalismo: il minimalista disprezza la corsa all’inutile, dedica la propria esistenza al reperimento delle risorse in grado di soddisfare le sue più impellenti necessità fisiche. Si tratta prevalentemente di giovani che vedono nel denaro solo un mezzo per rispondere ai bisogni più elementari. Scrive l’Autore: «È indubbiamente incredibile constatare quanto poco costi vivere seguendo i princìpi del minimalismo e quanto enorme sia invece la spesa per appartenere a una società. Da alcune stime fatte nelle città più industrializzate, è risultato che il 75 per cento dello stipendio di un lavoratore viene destinato a costi di appartenenza (fisco soprattutto), a spese relative a mezzi come l’automobile, all’arredamento della casa, all’abbigliamento. Voci che mancano completamente nella condizione del minimalismo». Questa nuova corrente di pensiero sostiene uno stile di vita spensierato, si sottrae ai giochi di potere volti al profitto che fanno leva sulla necessità di sicurezza degli individui, preferendo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato quelli brevi o brevissimi.
«Se il tema della sicurezza è quello più avvertito, è segno che il singolo e la società temono di ritrovarsi di fronte al rischio di finire, e dunque l’uomo e le società non possono che essere guidati dall’istinto di sopravvivenza», asserisce l’Autore. La paura è vissuta dal singolo, ma si propaga in forma endemica, coinvolgendo persino interi popoli − si pensi alla paura generata dalle guerre o dalle malattie, combattuta principalmente con la speranza e la fede −;; questa diffusione dei sentimenti «è un indice che il singolo uomo è una finzione, o quantomeno che a dominare è il noi, inteso come una rete di interconnessioni sociali».
È interessante constatare come l’uomo ricerchi sempre la sicurezza, pur rimanendo affascinato dal pericolo e dalle vie insicure, soprattutto nella fase adolescenziale; è altrettanto vero, inoltre, che spesso una condizione di sicurezza è raggiungibile solo attraverso il rischio: si pensi, ad esempio, all’operato dei chirurghi. Si può dunque affermare che all’interno di una società la dimensione della sicurezza e quella dell’insicurezza devono necessariamente convivere. Dopotutto, l’uomo sicuro non avrebbe bisogno dell’altro, di quei legami che diventano essenziali poiché rappresentano la vita.
Scrive Andreoli:
Homo incertus
Il bisogno di sicurezza nella società della paura
Collana «Saggi»
Rizzoli (Mi) 2020, pp. 360
€ 18,50
© Bioetica News Torino, Marzo 2020 - Riproduzione Vietata